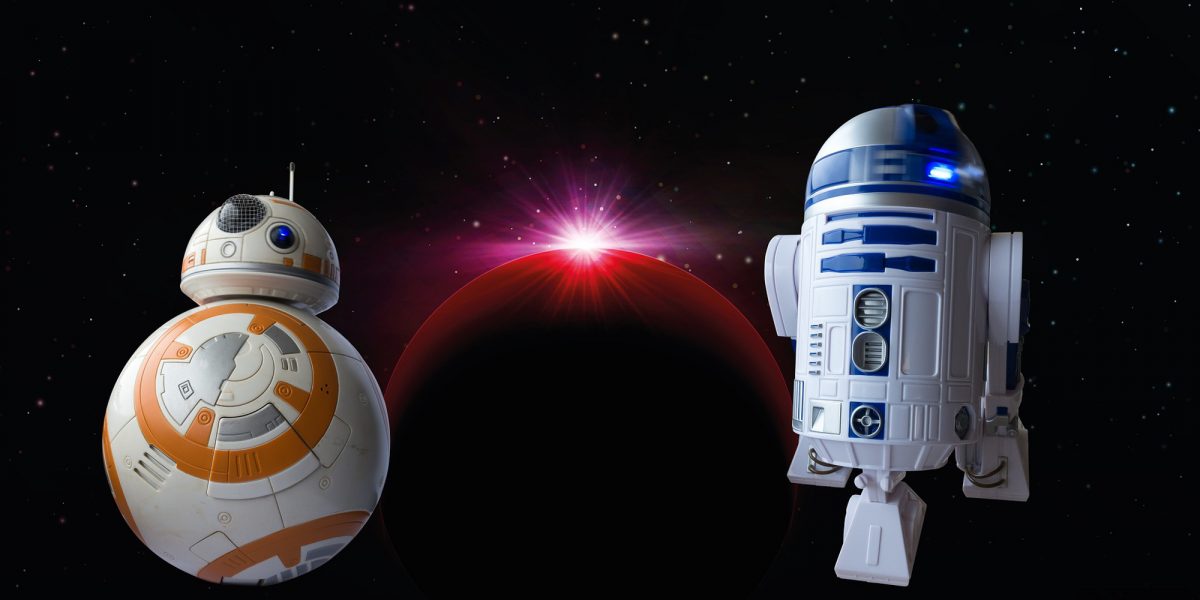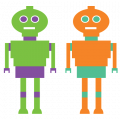Da una parte c’è la robotica tradizionale, che esiste da almeno cinquant’anni e che viene usata nell’industria fondamentalmente per carichi pesanti e alta velocità. Dall’altra quella collaborativa, che c’è da meno di dieci e che viene invece utilizzata per carichi leggeri e velocità decisamente più basse. Il primo cobot lanciato da Universal Robots portava 5kg, contro una tonnellata che può arrivare a portare un robot tradizionale, e aveva una velocità massima di un metro al secondo. Oggi la tecnologia ha fatto passi avanti, ma è ancora la robotica tradizionale a trovare maggior impiego nelle fabbriche.
Secondo i dati raccolti dalla International Federation of Robotics (IFR) nel 2020 sono state 384mila le installazioni in tutto il mondo di robot industriali (quindi tradizionali e collaborativi), leggermente in crescita rispetto al 2019 (382mila), ma non ancora in grado di raggiungere le 400mila circa del 2018. Dati che evidenziano un grande interesse da parte del mondo industriale per queste soluzioni, che hanno tra i principali mercati di sbocco l’elettronica e l’automotive.
Ma quando può avere senso implementare un cobot in un processo produttivo? Per quali funzioni queste soluzioni sono più indicate? E quali sono le principali limitazioni tecniche e normative che frenano la diffusione della robotica collaborativa nelle fabbriche?
Lo abbiamo chiesto ad Andrea Maria Zanchettin, professore associato del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano, nonché grande esperto di robotica collaborativa.
Su 384mila installazioni effettuate nel 2020, 362mila sono state di robot tradizionali e solo 22mila di cobot. Come mai questa forte disparità e, soprattutto, ha senso investire nella robotica collaborativa?
“Intanto dobbiamo partire da due premesse: la robotica collaborativa ha una storia molto recente e, soprattutto, è una tecnologia di tipo disruptive. Si tratta cioè di un qualcosa che prima non c’era, ma che non è arrivata a sostituire l’esistente; è – al contrario – entrata in un mercato, costruendoselo, il che implica che abbiamo a che fare con una tecnologia completamente diversa da quella utilizzata per la robotica tradizionale.
I dati dicono che investire in un robot collaborativo potrebbe avere senso. A dispetto del fatto che se ne parla tantissimo, va comunque tenuto presente che abbiamo a che fare con numeri ancora molto piccoli rispetto a quelli della robotica tradizionale. Pensiamo solo che le installazioni di robotica collaborativa nelle fabbriche del mondo sono passate dal 2,75% del 2017 al 5,73% nel 2020 (ultimi dati disponibili). Se però da una parte è vero che stiamo parlando di una nicchia, vero è anche che c’è stata una crescita importante negli ultimi tre anni, che può farne presupporre un buon potenziale di crescita.
Ma se si ha a che fare con un prodotto destinato a crescere nelle aziende, andrebbe capito – informazione di cui però non si è a conoscenza – quale è l’effettiva capacità produttiva di cobot da parte dei costruttori, così da comprendere se siamo di fronte a una saturazione di tale capacità che potrebbe rallentarne la diffusione oppure no”.
Robot tradizionali VS cobot: i primi sono più veloci e portano più peso, i secondi sono ideali per i processi produttivi caratterizzati da bassa velocità e carichi relativamente bassi. Ma sono solo queste le differenze?
“No, c’è un altro aspetto molto importante da considerare che spesso passa in secondo piano, ovvero la facilità di installazione di un cobot. Ed è proprio su questo terzo asse che la robotica collaborativa vince rispetto a quella tradizionale.
Un robot industriale di tipo tradizionale è – secondo gli standard ISO – un robot multifunzione e riprogrammabile. Nonostante questa definizione ben precisa, nella pratica poi non è così. Nel senso che se andiamo ad analizzare le varie applicazioni industriali, ci rendiamo conto che un robot industriale di tipo tradizionale in genere nasce e muore svolgendo la stessa funzione. Quindi avrebbe il potenziale per essere destinato ad altre attività, ma poi, nella pratica, questo non avviene mai a causa delle grandi difficoltà legate alla riprogrammazione delle istruzioni, e alla installazione vera e propria con tutti gli attrezzaggi del caso.
Questa problematica tendenzialmente non esiste se si ha a che fare con robot di tipo collaborativo, proprio perché la robotica collaborativa nasce per massimizzare la facilità d’uso e di riprogrammazione. Quindi lo compro perché oggi mi serve per una determinata funzione, sapendo che domani sarò in grado in maniera abbastanza semplice di riprogrammarlo e reinstallarlo per una funzione diversa senza dover chiedere il supporto di un system integrator o di un esperto di robotica”.
E a livello di costi?
“Dipende. Nel senso che se parliamo di robot inteso come organo meccanico più la relativa unità di controllo, possiamo dire che in linea di massima i costi di un cobot e quelli di un robot tradizionale si equivalgono (forse quelli dei collaborativi sono leggermente superiori). Vero è anche però che la facilità d’uso è sicuramente un asset che va a diminuire i costi di esercizio, abilitando – di fatto – la possibilità di riutilizzare il cobot, invece che acquistarne un altro (cosa non da poco!).
Se consideriamo però che – alla fine di tutto – l’azienda non investe in un robot, bensì in una installazione robotica o in un’isola robotica, allora i costi di un’applicazione di robotica collaborativa sono decisamente inferiori, rispetto a quelli di un’applicazione di robotica tradizionale. Questo perché se parliamo di robotica tradizionale sarà sicuramente necessario avere spazio a disposizione (perché si tratta di una soluzione ingombrante), di infrastruttura perimetrale (quindi gabbia o barriere ottiche), di attrezzaggi (incluso chi li progetta) e di ingegnerizzazione dell’applicazione. Se invece parliamo di robotica collaborativa è possibile – come abbiamo detto – abbattere di molto i costi relativi a riprogrammazione e installazione, a cui si aggiunge il fatto che questo genere di soluzioni possono funzionare senza barriere perimetrali, altro costo netto da togliere all’investimento complessivo”.
Per quali applicazioni ha senso investire in un robot collaborativo?
“Come abbiamo detto le soluzioni di robotica collaborativa non vanno a sostituire quelle di robotica tradizionale, ma si utilizzano laddove non era pensabile mettere un robot tradizionale.
Se ci limitiamo – e per ora guardando i numeri è così – al manifatturiero, le applicazione dove il robot collaborativo è più indicato sono quelle dedicate al carico/scarico per macchine utensili o centri di lavoro in sostituzione dell’operaio. E poi anche di assemblaggio, packaging, fine linea, piuttosto che di ispezione test soprattutto in ambito elettronico.
Dal mio punto di vista, però, si sta andando verso una graduale saturazione di queste applicazioni. Quindi la tecnologia che c’è oggi va bene per queste funzioni, da osservatore ne prendo coscienza e, se ho a che fare con quel tipo di applicazioni, allora posso pensare di investire in questa direzione perché so che funziona. Il prossimo step dovrebbe però essere quello di progettare e testare queste soluzioni per nuove applicazioni”.
In un settore come quello della microcomponentistica meccanica, dove – com’è noto – si lavora con tolleranze molto ristrette, ha senso impiegare un collaborativo per operazioni come quelle di assemblaggio?
“Al momento no; anche il robot più preciso del mondo non è in grado, a oggi, di svolgere operazioni di questo tipo, proprio perché l’indicatore di precisione – pur essendo molto interessante – non è quello più importante da analizzare.
Partiamo dal presupposto, infatti, che una persona non è precisa come un robot. È grossolana nei movimenti, non è in grado di arrivare al decimo o addirittura al centesimo di millimetro, ma, nonostante questo, riesce a svolgere operazioni di assemblaggio meglio di un robot. Questo perché la persona – a differenza di un robot – possiede anche capacità tattili e capacità visive.
La tecnologia ha già fatto enormi passi avanti in questa direzione e ormai quasi tutti i robot collaborativi sono dotati di almeno una cella di carico sulla flangia, che permette di misurare forza e movimento, e quindi, di fatto, hanno già il senso del tatto. Molti di questi sono anche già dotati di sensoristica al polso, il che significa di fatto che hanno anche la vista.
Questo vuol dire che la tecnologia è ragionevolmente matura per iniziare a pensare ad applicazioni nel micro assemblaggio, manca solo lo step successivo. Ovvero trovarsi a doverla tradurre per un caso applicativo, così da verificare se effettivamente si tratta di una tecnologia che ha ancora dei limiti concreti oppure no”.
Esistono delle limitazioni a livello normativo che frenano la diffusione della robotica collaborativa nelle fabbriche?
“Le limitazioni normative non riguardano il robot in sé, bensì l’applicazione.
Gli ostacoli normativi quindi esistono e sostanzialmente sono trascrizioni a livello matematico e ingegneristico del buon senso, ovvero la sicurezza del lavoratore che viene prima di tutto. Va capito però se questa norma costituisce davvero una barriera ON/OFF, quindi l’applicazione non la posso robotizzare perché non sono in grado di garantire la sicurezza del lavoratore, oppure se la normativa costituisce una barriera alla produttività. Va capito, in altre parole, se l’infrastruttura di sicurezza (che diamo per assunto esista) vada a limitare la produttività e quindi a dilatare il payback time (quindi il ritorno dell’investimento che in genere va dai 6 ai 18 mesi al massimo) oppure no. E se sì, di quanto”.